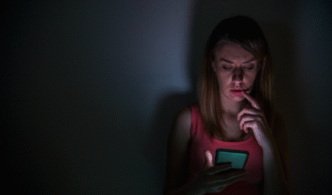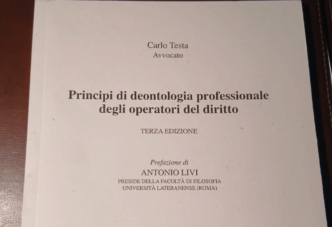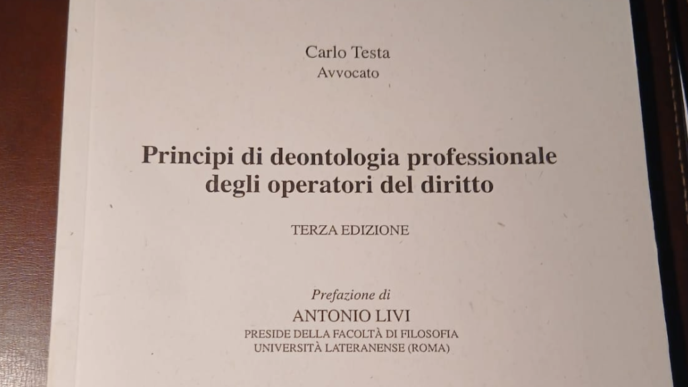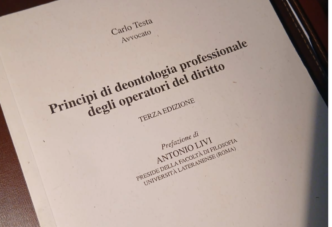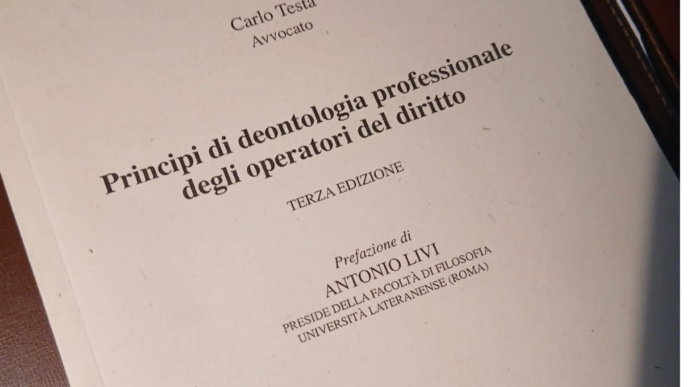Empatia, inclusione sociale, maggiori interventi legislativi queste sono le chiavi mancanti per una società moderna e rispettosa dei diritti umani a tutti i livelli: un patto di corresponsabilità tra Famiglia, Scuola ed Istituzioni per favorire la comprensione dell’altro diviene strumento utile e necessario per prevenire ogni forma di abuso.
Studio a quattro mani di Cristina Di Silvio e Maurizio Colangelo.
L’empatia, non a caso, passa anche attraverso una forma di educazione civica dell’essere umano e su questo gli adulti, che agiamo come soggetti, qualificati e competenti, in ogni segmento ed aspetto della società civile, hanno il dovere di cogliere ed intercettare questo profilo in modo positivo e stimolarlo in modo propositivo a tutti i livelli.
Il ruolo dell’empatia, soprattutto cognitiva, è cruciale nel giudizio umano. Il non interpretarlo o saperlo applicare comporta inevitabilmente pervicaci conseguenze negative nell’ambito della società e soprattutto tra i giovani che sono i maggiori soggetti più fragili nel non comprendere l’importanza di questa forma di comunicazione tra propri simili.
Non parlo dell’empatia da un punto di vista psicologico, sarebbe una inutile ed incompetente invasione di campo, ma per quello che riguarda i riflessi nel mio settore.
Da un punto di vista meramente pragmatico/giuridico la mancanza di empatia nel nostro “ vivere quotidiano e sociale” ha prodotto quel fenomeno odioso della prevaricazione di un soggetto verso l’altro che è denominato bullismo ed il bullismo può assumere differenti forme criminali che si manifestano come lievi o più gravi forme di coercizione psichica e fisica, sino ad arrivare a vere proprie azioni illecite a danno di esseri umani, come in determinati casi, oggetto di ricorrenti notizie di cronaca, quelle del femminicidio o della istigazione al suicidio, se non attentamente monitorati questi fenomeni dalle strutture territoriali.
Oggi la mancanza di empatia tra i giovani si traduce, in molteplici situazioni, vuoi per disorientamento culturale, valoriale o per mancanza di punti di riferimento, in prevaricazioni che determinano veri e propri illeciti civili e penali, che molto spesso finiscono sul tavolo dei magistrati minorili e non solo, se trattasi di adolescenti maggiorenni.
E’ assai importante coltivare una maggior cultura e sensibilizzazione alla empatia tra i giovani, attraverso un dialogo interistituzionale tra giovani e i soggetti che operano sul territorio e non su un territorio qualsiasi ma dentro le scuole e all’interno delle famiglie, quali i docenti e i genitori, affiancati da soggetti che sanno interloquire con i discenti e spiegare dentro e fuori dalle scuole le cause che danno origine a queste forme di violenza, la cui base fattuale è, spesso, proprio determinata da un difetto esplicito di empatia tra le nuove generazioni: quindi, abituarli, con il dialogo diretto, all’approfondimento di tale forma di comunicazione per comprendere i propri coetanei.
Rafforzare lo strumento del dialogo degli adolescenti con competenti soggetti nell’ambito, ad esempio, della educazione civica, nelle scuole ed all’interno della materia e anche tramite incontri con le famiglie ed i genitori, permetterebbe di conseguire quell’obiettivo sociale di una inclusione reale e concreta e la possibile realizzazione di una consequenziale trasformazione di una società maggiormente accogliente e tollerante.
Come operatore del diritto a contatto con le problematiche dei giovani, quale magistrato, oltre che essere un genitore adottivo di un ragazzo proveniente dall’Africa, con tutte le sue evidenti difficoltà di integrazione, ho cercato di individuare le cause del disagio sociale delle nuove generazioni e, soprattutto, proponendo misure per contenere il fenomeno della violenza in genere e del bullismo, tutto ciò anche cercando di portare un concreto messaggio, tramite il dialogo concreto, in molte scuole del nostro paese, ove sono stato chiamato, e parlando direttamente con gli alunni, ascoltandoli e cercando di capire il loro punto di vista.
Non sottovalutiamo che i ragazzi hanno sete di conoscere, non pensiamo che gli stessi siano estranei alle dinamiche politiche della nostra società, lo diventano solo se noi siamo in grado di offrire delle prospettive e dei momenti di riflessione costruttivi, in molti casi ho avuto nei dialoghi con loro ragazzi nelle scuole che mi hanno praticamente sommerso di domande, perché loro hanno necessità di avere punti di riferimento di cui fidarsi per ampliare le loro sfere di conoscenza.
Molti di questi ragazzi alla domanda cosa era l’empatia e le conseguenze derivanti dalle azioni di bullismo non sapevano nemmeno quale risposta dare e questo pone un’altra questione: perché i ragazzi non sapevano dare una risposta?
Ovviamente perché essi non ne parlano con gli adulti e perché i ragazzi di oggi sono abituati a viaggiare su documenti spesso fuorvianti e reperiti solo sulla rete.
D’altra parte per queste giovani generazioni il fatto empatico di non comunicare espressamente con un coetaneo è divenuto virale, basta che dialoghino tra loro attraverso le icone proposte dalla rete, una faccina o un cuoricino, senza comprendere che una carezza o l’offerta di un fiore fisicamente ad una coetanea, ha, sicuramente, tutt’altro significato che mandarlo per via della rete.
Le emozioni che si provano ed abbiamo provato noi come generazione negli anni della adolescenza sono sicuramente sottovalutate dai giovani di oggi e danno per scontato tutto, quando invece l’emozione, prodotto dalla empatia, ha un ruolo importantissimo sia sotto il profilo emotivo sia nella formazione di un essere umano perché fa comprendere “a pelle” ciò che è positivo rispetto a quello che non si deve seguire.
La mancanza di un percorso empatico, pertanto, è evidente che porta questi adolescenti a cogliere aspetti solo marginali del proprio comportamento e a non comprendere con consapevolezza preventiva e critica circa le conseguenze, in termini disciplinari e giudiziari, delle deprecabili azioni commesse e dei danni provocati o che si provocano in chi subisce i comportamenti da loro posti in essere in forme violente e prevaricatrici che possono, come detto, sfociare in forme di reato perseguibili dal nostro Ordinamento giuridico ed in atti di bullismo e cyberbullismo e quando si diviene più adulti in femminicidi.
Purtroppo se non si educano, oggi e non domani,…………., i giovani al rispetto dell’altro, con continui dialoghi intergenerazionali, l’evoluzione in negativo di queste condotte porta e, sicuramente, porterà, quando essi diventeranno più grandi, a consumare atti illeciti ancora più gravi rispetto ad un atto di mera violenza privata dal sapore “bullistico” e non dimentichiamoci che anche l’atto di bullismo, di per sé, è già un atto grave che po’ condurre una persona altamente fragile ad atti di autolesionismo.
L’educazione all’empatia nasce dalla famiglia.
In sede legislativa come operatore del settore mi sono reso in prima persona portavoce in Senato nell’aprile del 2023 portando idee su una materia importante quale quella del bullismo, non disciplinato sino a quel momento, sotto il profilo legislativo, differentemente dal cyberbullismo che era già codificato con una legge del 2017, e grazie a questa sensibilizzazione a maggio del 2024 con la Legge n. 70 si è addivenuti ad una disciplina innovativa sul tema che, ovviamente, non è esaustiva ma è un primo passo per poterla migliorare in futuro ed essere di supporto alle nuove generazioni e a tutti gli operatori all’interno delle scuole .
Mi permetto, in conclusione, di aggiungere che, anche a livello internazionale, le statistiche più recenti rese note dall’ONU evidenziano che nel mondo uno studente su tre, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo.
Nel mondo 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o restano coinvolti in episodi di bullismo.
Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento: la maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati con percentuali di minorenni che lo hanno subito, che variano tra il 5% e il 20% della popolazione minorile; le conseguenze psicofisiche vanno dal mal di testa ai dolori allo stomaco e/o si manifestano con mancanza di appetito e disturbi del sonno.
Nel nostro Paese, l’UNICEF Italia è attiva sul tema del bullismo e cyberbullismo su vari fronti. Da un lato opera sulla sensibilizzazione e formazione attraverso progetti e attività diffuse nel territorio, dall’altro dialoga con le istituzioni, promuovendo l’adeguamento della normativa italiana agli standard internazionali di riferimento, in modo tale da garantire un’azione pubblica sempre più efficace e rispettosa dei diritti dei minorenni.
L’UNICEF Italia fa parte dell’Advisory Board del progetto Safer Internet e, attraverso le sue attività di promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi rivolte al mondo della scuola, è impegnata nella promozione dell’uso sicuro della rete.
A tal proposito, si evidenzia che anche l’UNESCO sta portando avanti uno studio sulla violenza a scuola e sul bullismo.
Uno sguardo panoramico con riguardo ad altre realtà estere permette di evidenziare che:
– in Olanda, dal 2013, c’è un piano d’azione anti-bullismo: i programmi sviluppati sono soggetti a valutazione per una verifica di impatto ed efficacia, mentre quelli con valutazione positiva diventano obbligatori;
-in Grecia molti programmi che coinvolgono direttamente i minori nella fase di sviluppo, a cui seguirà quella esecutiva (approccio peer-to-peer): sono i ragazzi più grandi a spiegare ai più piccoli cos’è il bullismo e come reagire;
-in tutti i Paesi Membri dell’UE si registra l’incremento quantitativo di linee telefoniche dedicate all’ascolto dei minori, alcune anche raggiungibili online (Svezia);
-in Romania sussiste un progetto unitario che coinvolge una linea telefonica dedicata, un sito web e un meccanismo specifico per reagire ai contenuti illegali online.
Inoltre nell’occasione del mio intervento in Senato sono stati lanciati dei feedback legislativi riguardanti la questione della responsabilità degli amministratori dei siti internet, il cui principio cardine è contenuto nel Decreto legislativo n. 17 del 2003, in tema di commercio elettronico: esso costituisce un argomento strettamente connesso con quello oggetto dell’indagine, poi approfondito nel corso di alcune audizioni.
Tale Decreto legislativo stabilisce che il gestore della piattaforma sia esente da responsabilità per quanto veicolato sulla Rete, salvo l’obbligo di collaborazione con l’autorità giudiziaria e le forze di polizia.
Al riguardo la Corte di Cassazione, I sez. civ., con sentenza del 19 marzo 2019, n. 7708, aveva già chiarito che l’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che svolge un’attività che non è solo di ordine tecnico o automatico, ma pone in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito.
Con il mio intervento ho proposto di responsabilizzare maggiormente i gestori dei social nella verifica dei documenti inseriti dagli adolescenti, come, ad esempio, predisponendo non solo la chiusura del sito incriminato, bensì anche la comminazione di sanzioni pecuniarie elevate nei confronti dei gestori attraverso una commissione internazionale, anche perché il danno di diffusione in rete sarà stato ormai consumato nel momento in cui il gestore riceve l’istanza di chiusura del website ove risultavano inseriti i contenuti incriminati.
Si è del parere che il rischio di una sanzione pecuniaria comminata da una commissione internazionale avrebbe un valore sicuramente dissuasivo e preventivo. Lo Stato dovrebbe avviare canali di comunicazione o cooperazione con i gestori, anche a fini preventivi, per fare installare sistemi di geo-localizzazione e rilevare dove la vittima, almeno sino a quando è minorenne, si trovi in ogni momento, al fine di disporre di poter ricevere un messaggio ALLERT, laddove emergano ipotesi di rischio di comportamenti illeciti a suo danno; tanto, soprattutto qualora l’adolescente rimanga fermo nel medesimo luogo per un certo tempo reiterato, sempre previa denuncia dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
In sede di consesso senatoriale ho personalmente segnalato la necessità inderogabile che il legislatore si renda parte diligente, anche dinanzi alle istituzioni europee, per creare un organismo internazionale, quale un’agenzia specializzata per tale problematica, a fianco a quello già predisposto dall’ organismo dell’UNICEF, che, a differenza di quasi tutte le altre agenzie ONU, non è direttamente finanziato dal sistema delle Nazioni Unite.
Questo nuovo organismo, qualora venisse istituito su proposta dell’Italia (di grande rilevanza sociale e ben specifico all’interno delle istituzioni europee) verrebbe incaricato a livello sovranazionale di effettuare un monitoraggio, dei casi di cyberbullismo e bullismo e, conseguentemente, di indirizzare gli organi legislativi sovranazionali nell’applicazione di soluzioni.
In conclusione, avverto l’esigenza di richiamare due motti in lingua latina che sembrano sintetizzare quali debbano essere i fattori ineludibili da tenere ben presenti per fronteggiare e vincere la lotta al bullismo e al cyberbullismo e consolidare l’empatia nelle nuove generazioni: Quae sunt Caesaris, Caesari: riconoscere le responsabilità e i diritti di ciascuno; Per aspera ad astra: attraverso le difficoltà si arriva alle stelle o, meglio, superando gli ostacoli si raggiungono i grandi obiettivi.
Curriculum di Maurizio Colangelo
Magistrato di Tribunale (giudice tutelare) ed ex avvocato
Docente a contratto universitario master primo livello